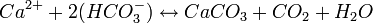Recentemente per indicare fenomeni di sprofondamento di qualsivoglia genere viene sempre più spesso utilizzato, da esperti del settore e non, il termine "sinkhole", che ha quasi del tutto sostituito altri termini più specifici, (dolina, camino di collasso, sprofondamento, limesink, cenotes, pozzo carsico, loess karst, voragine) generando una notevole confusione terminologica.
Il termine sinkhole (che tradotto letteralmente significa “buco sprofondato”) è stato introdotto per la prima volta da Fairbridge (1968) per indicare una depressione di forma sub-circolare dovuta al crollo di piccole cavità carsiche sotterranee, sinonimo dunque di dolina (doline).
Successivamente il termine è stato ripreso da alcuni Autori (Monroe, 1970; Jennings, 1985; White, 1988 ed altri) ed affiancato da un attributo che ne chiariva la genesi: sono stati distinti così tra i fenomeni carsici fenomeni di solution sinkhole, collapse sinkhole e subsidence sinkhole (coincidenti con i termini di solution doline, collapse doline, subsidence doline introdotti da Cramer, 1941 e successivamente utilizzati anche da Castiglioni nel 1986 in Italia e da molti altri Autori, dolina di soluzione normale, dolina di crollo, dolina alluvionale, dolina di subsidenza in roccia).
Attualmente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il termine sinkhole viene usato frequentemente e definisce una qualunque cavità nel terreno di forma non più necessariamente sub-circolare, apertasi per cause antropiche o per motivi diversi.
In Italia il termine sinkhole è stato introdotto, a partire dagli anni novanta, per indicare un tipo particolare di sprofondamento, con forma sub-circolare, ma di genesi incerta.
Successivamente anche in Italia il termine è stato usato secondo l’accezione anglosassone, sinonimo dunque di sprofondamento s.l., di dolina, di sprofondamento antropico, e di “camino di collasso”.
Il termine sinkhole nella letteratura italiana indicava, in principio, ampie e profonde depressioni di forma sub-circolare con diametro e profondità variabili da pochi metri a centinaia di metri, a pareti sub-verticali che si aprono rapidamente in terreni a granulometria variabile.
Questi tipi di sprofondamenti sono quasi sempre colmati da acque, spesso mineralizzate, formando laghetti e specchi d’acqua; sono caratterizzati da subsidenza che può localmente essere dovuta a presenza di sorgenti.
Tali fenomeni sono localizzati in genere su allineamenti tettonici lungo i quali spesso si evidenziano anomalie di fluidi; la continua erosione delle pareti del camino provoca il progressivo colmamento della voragine, un aumento del diametro e nello stesso tempo una diminuzione della profondità dello specchio d’acqua se presente.
La formazione di questi fenomeni è improvvisa, può essere realizzata in un evento unico o in più eventi con progressivo cedimento delle pareti.
I meccanismi di erosione dal basso potrebbero essere assimilati a processi di suffosione profonda (deep piping), definiti da Castiglioni (1986) come effetti meccanici dello scorrimento sub-superficiale (in questo caso però il movimento sarebbe profondo) dell’acqua nel terreno (con dimensioni granulometriche dalle argille alle ghiaie), che si realizza quando quest’ultimo è crepacciato o poroso e quando l’acqua abbondante e con pressione elevata riesce a trovare vie di scorrimento in cui passare con velocità abbastanza sostenuta. Il passaggio dell’acqua provoca l’erosione di materiale e la formazione di canalicoli e di condotti tubolari lungo le linee idrauliche di flusso. Quest’ultimo fenomeno viene indicato nella letteratura anglosassone con il termine piping.
Sprofondamenti in cui è stata accertata la presenza di meccanismi di questo tipo possono venire definiti, aggiungendo un attributo al termine per specificarne la genesi: piping sinkhole.
 |
| What has been called a "sinkhole" by the popular press formed suddenly in Guatemala in May 2010. Torrential rains from Tropical Storm Agatha and a bad drainage system were blamed for creating the 2010 "sinkhole" that swallowed a three story building and a house. This large vertical hole measured approximately 66 feet (20 m) wide and 100 feet (30 m) deep. A similar hole had formed nearby in February 2007.This large vertical hole, called a "sinkhole" in the popular press, is not a true sinkhole as it did not form via the dissolution either of limestone, dolomite, marble, or any other carbonate rock. Guatemala City is not underlain by any carbonate rock; instead, thick deposits of volcanic ash, unwelded ash flow tuffs, and other pyroclastic debris underlie all of Guatemala City. Thus, it is impossible for the dissolution of carbonate rock to have formed the large vertical holes that swallowed up parts of Guatemala City in 2007 and 2010. The large holes that swallowed up parts of Guatemala City in 2007 and 2010 are a spectacular example of "piping pseudokarst", created by the collapse of large cavities that had developed in the weak, crumbly Quaternary volcanic deposits underlying the city. Although weak and crumbly, these volcanic deposits have enough cohesion to allow them to stand in vertical faces and develop large subterranean voids within them. A process called "soil piping" first created large underground voids as water from leaking water mains flowed through these volcanic deposits and washed fine volcanic materials out of them, then progressively eroded and removed coarser materials. Eventually, these underground voids became large enough that their roofs collapsed to create large holes. |