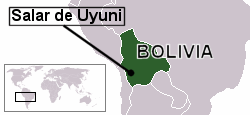METODOLOGIA DI SISMICA PASSIVA
METODOLOGIA DI SISMICA PASSIVA
(Tratto da F. Mulargia, S. Castellano e P.L.Rossi, 2008)
Il rumore sismico, generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica, è presente ovunque sulla superficie terrestre. Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai terremoti nel campo prossimo all’epicentro. A questo rumore di fondo, che è sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie, ecc.) e naturali. I microtremori sono solo in parte costituiti da onde di volume, P o S. In essi giocano un ruolo fondamentale le onde superficiali, che hanno velocità prossima a quella delle onde S (vedi ad es. Lachet e Bard, 1994), il che spiega la dipendenza di tutta la formulazione dalla velocità di queste ultime.
Dai primi studi di Kanai (1957) in poi, diversi metodi sono stati proposti per estrarre l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore sismico registrato in un sito. Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso è quella dei rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V, proposta tra Nogoshi e Igarashi (1970).
Le basi teoriche dell’H/V sono relativamente facili da comprendere: in un mezzo strato + bedrock (o strato assimilabile al bedrock) in cui i parametri sono costanti in ciascun strato, consideriamo il sistema in cui gli strati 1 e 2 si distinguono per le diverse densità (r1 e r2) e le diverse velocità delle onde sismiche (V1 e V2) . Un’onda che viaggia nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall’interfaccia che separa i due strati. L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le ampiezze massime (condizione di risonanza) quando la lunghezza dell’onda incidente (l) è 4 volte (o suoi multipli dispari) lo spessore H del primo strato. La frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle onde S è pari a:
[1] fr = Vs1/4H
Questo effetto è sommabile, anche se non in modo lineare e senza una corrispondenza 1:1.
Ciò significa che la curva H/V relativa ad un sistema a più strati contiene l’informazione relativa alle frequenza di risonanza (e quindi allo spessore) di ciascuno di essi, ma non è interpretabile semplicemente applicando l’equazione [1].
L’inversione richiede l’analisi delle singole componenti e del rapporto H/V, che fornisce un importante normalizzazione del segnale per:
a) il contenuto in frequenza
b) la risposta strumentale
c) l’ampiezza del segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore di fondo più o meno alto.
La situazione, nel caso di un suolo reale, è spesso più complessa. Innanzitutto il modello di strato piano al di sopra del bedrock si applica molto raramente. Poi, la velocità aumenta con la profondità, possono esserci eterogeneità laterali ed infine la topografia può non essere piana. L’inversione delle misure di tremore a fini stratigrafici, nei casi reali, sfrutta quindi la tecnica del confronto degli spettri singoli e dei rapporti H/V misurati con quelli “sintetici”, cioè con quelli calcolati relativamente al campo d’onde completo di un modello 3D. L’interpretazione è tanto più soddisfacente, ed il modello tanto più vicino alla realtà, quanto più i dati misurati e quelli sintetici sono vicini (per le basi teoriche si veda ad es. Aki, 1964; Ben-Menahem e Singh, 1981; Arai e Tokimatsu, 2004).