giovedì 25 gennaio 2018
Libro: Le forme del rilievo. Atlante illustrato di geomorfologia
martedì 23 gennaio 2018
Libro: Vulcani d'Italia
La vista di una colata di lava che scorre come un denso fiume incandescente è uno degli spettacoli più affascinanti e impressionanti offerti dalla natura. Chiunque vi assista, inevitabilmente, si chiede da dove venga, come si formi e per quanto tempo continuerà a risalire da sotto terra questo materiale così insolito, pericoloso e bello nello stesso tempo. L’attività vulcanica suscita da sempre un misto di terrore e di irresistibile fascino e, nel corso dei secoli, molti si sono cimentati nel descrivere le sensazioni suscitate dalle eruzioni vulcaniche. Nel 1877, Renato Fucini, osservando il Vesuvio in attività, riassumeva buona parte di queste sensazioni, scrivendo «...Non v’è sguardo umano, io credo, in questa regione che la sera si chiuda senza aver guardato la cima della montagna. (…) Il dotto la osserva per misurare la sua piccolezza di fronte ai grandi misteri della natura; l’ignorante vi posa volentieri lo sguardo, perché tanta bellezza è accessibile anche alle menti più ottuse». Questo libro dedicato ai vulcani d’Italia cerca di riassumere almeno in parte il grandioso sforzo di conoscenza realizzato dalla comunità vulcanologica italiana in questi anni di proficuo lavoro. Gli Autori hanno cercato di riassumere per ciascun vulcano il patrimonio di conoscenze sulla struttura ed evoluzione vulcanologica, così come il contesto storico e sociale cresciuto attorno al vulcano. Non si tratta solo dei vulcani attivi o quiescenti, ma si presentano tutti i vulcani che hanno dispiegato la loro attività in un periodo geologico recente. L’opera, unica nel suo genere, è utile non solo per gli studiosi della materia, ma soprattutto per quanti, curiosi della natura, vogliano meglio conoscere il territorio in cui si trovano.
Ospiti caldi e freddi del Mediterraneo
 |
| Strombus bubonius |
 |
| Arctica islandica |
Durante il Pleistocene (iniziato circa 1.800.000 anni fa e terminato 10.000 anni fa) lunghi periodi freddi, alternati a brevi periodi caldi, si sono ripetuti più volte interessando soprattutto l'emisfero settentrionale.
I periodi freddi, detti glaciazioni, erano caratterizzati da una marcata diminuzione della temperatura, che causò l'estendersi dei ghiacciai, delle calotte polari e il conseguente abbassamento del livello marino, favorendo così
Nei periodi caldi, chiamati interglaciali, l'innalzamento della temperatura determinò lo scioglimento di parte delle masse glaciali e l'aumento del livello del mare disegnò linee di costa più alte di quelle attuali.
Conseguentemente a questi cambiamenti climatici, le flore e le faune marine e continentali più sensibili alle variazioni di temperatura, si spostarono seguendo le avanzate e le regressioni glaciali e i fossili che oggi troviamo, ci danno precise indicazioni sui diversi climi succedutisi.
I molluschi fossili qui esposti, provenienti da depositi marini del Pleistocene italiano, sono chiari esempi di "fossili climatici" e significative testimonianze di queste migrazioni.
Infatti nei periodi glaciali sono arrivati nel Mediterraneo gli "ospiti freddi", quali Arctica islandica, Panopea norvegica, Mya truncata e Neptunea contraria , che attualmente vivono lungo le coste del Mare Baltico e dell'Oceano Atlantico settentrionale.
Invece nell'ultimo interglaciale, durante il quale la temperatura media annuale era più alta di quella odierna, sono arrivati dalle coste atlantiche africane gli "ospiti caldi" come Strombus bubonius, Conus testudinarius, Brachidontes senegalensis e altre specie, che attualmente vivono nelle coste tropicali del Senegal.
lunedì 22 gennaio 2018
Latimeria - Celacanto - Contiene Video
Latimeria Smith, 1939 è l'unico genere esistente della famiglia dei Latimeriidi; ad esso appartiene il celebre Celacanto (dal greco coilia (κοιλιά), "vuoto", e acanthos (ἄκανθος), "spina"). Quest'ultimo è un rappresentante della più antica linea evolutiva di pesci che si conosca.
Si pensava che i celacanti fossero estinti sin dal Cretaceo, fino a quando un esemplare venne pescato nel 1938 in Sudafrica, nell'Oceano Indiano all'altezza della foce del fiume Chalumna. In seguito furono trovati altri esemplari nelle isole Comore, Sulawesi, in Indonesia, Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar e in Sudafrica, nell'area protetta iSimangaliso Wetland.
Il celacanto fa parte della classe dei Sarcopterigi; secondo i fossili ritrovati, i celacanti apparvero per la prima volta nel Devoniano medio, circa 390 milioni di anni fa. In media un celacanto raggiunge gli 80 kg, una lunghezza di due metri e una aspettativa di vita di 60 anni circa.
Gli occhi del celacanto sono estremamente sensibili alla luce, grazie alla presenza del tapetum lucidum, una membrana riflettente posta dietro alla retina che riflette nuovamente la luce catturata alla retina; per questo motivo è molto difficile catturare un celacanto di giorno o in una notte di luna piena.
Latimeria possiede pinne pari su peduncoli muscolosi dette omobasiche, ovvero sostenute da un solo asse osseo, anatomicamente omologo dell'omero e del femore dei tetrapodi. Queste pinne sono utilizzate prevalentemente per nuotare in acqua aperta piuttosto che per camminare sul fondale.
Sebbene oggi siano conosciute solo due specie di celacanti, nel Paleozoico e nel Mesozoico il gruppo dei celacantidi era molto numeroso e comprendeva diversi generi e specie; di questi esistono molti fossili databili dal Devoniano al Cretaceo, periodo dopo il quale i celacanti apparentemente si ritennero estinti, a seguito della estinzione di massa di fine cretacico dato che fino ad oggi non sono stati ritrovati fossili risalenti ad epoche successive.
La comparazione anatomica fra i resti fossili di pesci appartenenti ai Coelacanthiformes, lo stesso ordine del celacanto (soprattutto con i fossili del genere Macropoma del Cretaceo), e gli esemplari viventi attuali mostra chiaramente come questo ordine sia rimasto sostanzialmente invariato almeno negli ultimi 65 milioni di anni secondo una parte dei paleontologi o 300-400 milioni di anni secondo altri causando inizialmente un certo stupore fra gli studiosi, poiché il celacanto era ritenuto un progenitore degli anfibi, associato ad ambienti di acque poco profonde e progressivamente evolutosi fino a diventare adatto alla vita sulla terra ferma. Al contrario i ritrovamenti di forme viventi nel corso del XX secolo indicano che il celacanto odierno vive prevalentemente in acque profonde, dove non giunge alcuna traccia di luminosità .
Questa apparente contraddizione è tuttavia facilmente spiegabile con due osservazioni:
- la latimeria non vive solamente in acque profonde, fatto provato dalla scarsa profondità di pescaggio delle reti con cui i pescatori locali con cui viene pescato dagli ormai noti incontri di subacquei con esemplari viventi e sia con l'osservazione statistica, che il biologo P.L. Florey riporta nel suo trattato su questo pesce, che la maggior parte delle catture sono avvenute tra una profondità di 100 e 400 metri, mentre il maggior numero di avvistamenti visivi durante immersioni è avvenuto fra 190 e 210 metri, inoltre le sue osservazioni sembrano indicare che le oscillazioni batimetriche della isoterma di 18 °C possano influenzare la profondità di vita dell'animale
- nella crisi di fine cretaceo i celacanti si estinsero completamente nelle forme viventi in acque basse, costiere o dolci. Tuttavia gli animali che vivono in acque profonde sono molto difficilmente conservati allo stato fossile e raramente i loro resti fossili sono portati ad affiorare alla superficie terrestre dove i paleontologi possono scoprirli, cosicché può accadere che le specie di profondità scompaiano nella documentazione fossile. Inoltre l'etichetta di animale che non si evolse fisiologicamente dai tempi paleozoici, vulgata popolarmente appiccicata a questo phylum, non è corretta: gli sviluppi della ricerca paleontologica, nei decenni successivi alla scoperta della forma vivente e della formazione delle prime congetture, ha permesso di comprendere che le forme paleozoiche si evolsero e si irradiarono in diversi phylum, con un massimo di radiazione evolutiva nel Triassico, e i fossili di Macropora, l'ultimo genere più recente conosciuto allo stato fossile sono rinvenuti nei sedimenti del Cretaceo superiore del bacino anglo-parigino nella formazione calcarea del "chalk" ,per la quale l'ambiente marino deposizionale dovrebbe aver avuto una profondità fra 100 e 600 metri di profondità, quindi già le ultime forme fossili, di cui fino ad oggi si ha conoscenza, vivevano in un habitat simile alle forme attuali.
Foto: Google immagini
Smilodon - Tigre dai denti a sciabola
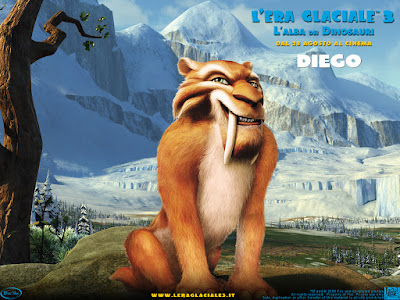 |
| Ricostruzione dello Smilodon nel film l'Era Glaciale. |
Misure:
Smilodon gracilis lungo circa 1.8 m per 90 – 100 kg.
Smilodon fatalis lungo almeno 2 m con punte di 2,3 e altezza al garrese 1,2 m, peso (stimato) da 200 a 300 kg.
Smilodn populator poteva raggiungere e superare i 450 kg, con media sui 300–400 kg per i maschi, altezza al garrese 1,45 m, lunghezza 2,6–3 m, anche più in esemplari più grandi.
 |
| Dimensioni dello Smilodon rispetto all'uomo |
Alimentazione: carne e carcasse, Epoca e ambiente: da 5 milioni a 10.000 anni fa, fino al tardo Pleistocene, nel Sudamerica e nel Nord America.
 |
| Ricostruzione museale di Smilodon |
Lo smilodonte era sicuramente il non plus ultra della catena alimentare della sua epoca. Cacciava tutti i grandi animali dell'epoca, compresi i mammuth, e alcuni studiosi pensano che attaccasse di solito in branco. Da una ricerca si evince che avesse una potenza del morso 1/3 di quella del leone attuale ma ciò è materia di discussioni. Il debole (forse) morso può essere spiegato dal fatto che i suoi canini (lunghi 15 e anche 20 cm) rompevano e dissanguavano una preda facilmente; il leone attuale, raggiungendo le sue zanne la lunghezza massima di 7 cm, deve uccidere per soffocamento e ha bisogno di una pressione molto superiore. Infine test dimostrano che le zanne dello Smilodonte, nonostante sembri il contrario, erano molto resistenti alla rottura, più di quelle della tigre e del leone, che pure sono corte e massicce."
domenica 14 gennaio 2018
Libro: L'indagine geotecnica di sito di Luigi Esposito
Le recenti calamità che hanno colpito il nostro paese - l'alluvione in Liguria e gli eventi sismici dell'Emilia - dimostrano che per difendersi in maniera efficace da questi eventi è necessaria una prevenzione basata su indagini, condotte con cura e volte ad accertare sia le condizioni del sottosuolo sia le caratteristiche delle strutture che poggiano su di esso. Il testo vuole essere uno strumento di rapida consultazione per i progettisti di opere civili e industriali, e descrivere in maniera sufficientemente chiara le caratteristiche dei vari tipi d'indagine, indicando anche i parametri che da essi si possono ricavare.
Link Amazon
sabato 13 gennaio 2018
Uluru - Ayers Rock
Uluru (chiamato in inglese Ayers Rock) è il più imponente massiccio roccioso dell'outback australiano. Circondato dalla superficie completamente piana del bush, Uluru è visibile da decine di chilometri di distanza ed è celebre per la sua intensa colorazione rossa, che muta in maniera spettacolare (dall'ocra, all'oro, al bronzo, al viola) in funzione dell'ora del giorno e della stagione; caratteristiche che ne fanno una delle icone dell'Australia. La superficie, che da lontano appare quasi completamente liscia, rivela avvicinandosi molte sorgenti, pozze, caverne, peculiari fenomeni erosivi e antichi dipinti.
L'Uluru si trova in Australia (Oceania) nel Territorio del Nord, nel Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta, 450 km a sudovest della città diAlice Springs. Si tratta di un luogo sacro per gli aborigeni, formalmente riconsegnato dal governo australiano agli indigeni del luogo nel 1985.
Uluru è il nome aborigeno originale del luogo. Si pensa derivi dalla parola ulerenye, una parola Arrernte che significa "strano". È anche un cognome comune nella zona.
Il primo non indigeno ad avvistare la formazione fu l'esploratore Ernest Giles, nell'ottobre del 1872. Vide il massiccio da molto lontano, e non poté avvicinarsi oltre a causa del lago Amadeus. Giles descrisse l'Uluṟu come "una pietra notevole" (espressione che non fu adottata come nome, a differenza di quanto accadde alle remarkable rocks di Kangaroo Island). Il 19 luglio dell'anno successivo, William Gosse battezzò la roccia Ayers Rock in onore dell'allora Premier del Sud Australia Sir Henry Ayers.
Nel 1993 fu istituita formalmente una doppia denominazione secondo la quale sia il nome aborigeno che quello inglese erano considerati nomi ufficiali. Il 15 dicembre 1993, Uluru fu ribattezzato Ayers Rock/Uluru e divenne la prima località con doppio nome nel Territorio del nord. Il 6 novembre del 2002, il nome duale fu ufficialmente rovesciato, diventandoUluru/Ayers Rock per richiesta dell'Associazione Regionale del Turismo di Alice Springs. Attualmente, il nome originale aborigeno è quello più utilizzato per indicare la roccia, mentre "Ayers Rock" è utilizzato solo per indicare il relativo aeroporto, il paese/resort (non è un vero e proprio paese) principale più vicino si chiama Yulara.
Uluru è definito un monolito, ma più precisamente è una parte di una formazione rocciosa monolitica molto più grande e in gran parte sotterranea che comprende anche i Kata Tjuta e il Monte Connor. L'Uluru si staglia per circa 320 m. rispetto al territorio circostante; ha un'altitudine di 864 m s.l.m.; ha un diametro di circa 8 km, ed è caratterizzato da una superficie molto dura e pareti estremamente lisce a strapiombo.
Caratteristica notevole del massiccio è il modo in cui esso sembra cambiare colore nelle diverse ore del giorno e nei diversi mesi dell'anno; alba e tramonto, in particolare, producono veloci variazioni di colore estremamente spettacolari (probabilmente la più grande attrazione turistica australiana). Questi effetti di colore sono dovuti a minerali come i feldspati che riflettono particolarmente la luce rossa. Il colore rosso del massiccio è dovuto all'ossidazione della componente ferrosa.
Vicino all'estremità ovest di Uluṟu si trova la comunità aborigena di Mutitjulu (pop. ca. 300). La popolazione locale si chiamaPitjantjatjara o Anangu (che significa "gente" in lingua Pitjantjatjara). A 17 km di distanza, appena fuori dal National Park, si trova invece il paese turistico di Yulara (pop. 3000).
 |
| Monti Kata Tjuta |
 |
| Monti Kata Tjuta |
giovedì 11 gennaio 2018
La Porosità
 |
| Elementi in materiale ceramico a elevata porosità |
In geologia degli idrocarburi la conoscenza della porosità viene considerata molto importante perché da questa dipende la maggior o minor capacità di immagazzinamento di idrocarburi.
La porosità è, inoltre, un parametro fondamentale in geotecnica per la classificazione delle rocce in base alle loro caratteristiche di permeabilità per la determinazione del loro comportamento sotto carico nelle diverse condizioni di saturazione.
La porosità influenza le velocità delle onde sismiche che attraversano le rocce, le densità delle rocce e quindi le misurazioni gravimetriche e la conducibilità elettrica di una roccia saturata con un fluido conducibile.
Continua su Wikipedia
mercoledì 10 gennaio 2018
Acqua - Alcune caratteristiche Fisiche
 |
Diagramma di stato dell'acqua. L'acqua congela a 0 °C se si trova a pressione atmosferica, ma per pressioni maggiori il congelamento avviene a temperature più basse.
|
 |
| Temperatura di ebollizione dell'acqua a varie altitudini - Clicca sull'immagine per ingrandirla. |
 |
| La concentrazione di sale nell'acqua ne fa aumentare la densità. Nel mar Morto essa è così elevata da permettere un agevole galleggiamento dei bagnanti. |
domenica 7 gennaio 2018
Cenere Vulcanica - Volcanic Ash - Contiene Video
La cenere si forma durante la fase esplosiva di un'eruzione. In quel momento le rocce si frantumano ed il magma si separa in minuscole particelle. Come conseguenza del flusso magmatico, durante la fase violenta si generano anche dei vapori (eruzione freatica), mentre parte della roccia solida che circonda il cono eruttivo, a causa del grande calore, viene trasformata in particelle di argilla nelle dimensioni di granelli di sabbia.
Il cono di cenere che spesso si vede durante un'eruzione vulcanica è principalmente composto da ceneri e vapori. L'espulsione di una grande quantità di cenere produce sia coni vulcanici sia strati che tendono a solidificarsi (vedi pozzolana) in tufo.
 |
| Eruzione del Monte Pinatubo nel 1991 |
L'evento più devastante che vede anche la presenza di ceneri vulcaniche è chiamato flusso piroclastico. Avviene in tutte quelle eruzioni vulcaniche in cui si crea una sorta di "valanga" di ceneri calde, gas e rocce che fluiscono ad altissima velocità lungo i fianchi del vulcano. È un flusso così veloce a cui è impossibile sfuggire. Nel 1902 la città di Saint-Pierre in Martinica fu distrutta da un flusso piroclastico che uccise più di 29.000 persone.
Particelle di ceneri vulcaniche molto sottili possono rimanere sospese nell'atmosfera per diversi anni, propagandosi per tutto il mondo nell'alta atmosfera grazie anche ai venti in quota.
Giant's Causeway - Contiene Video
GLYNDA:
Perhaps on first sight of this classic formation stepping as it were out of the sea, we can imagine how tempting it was to think, as did some early geologists known as Neptunists, that these rocks had a marine origin. But this is evidently not the case for the rock composing the Giant's Causeway in County Antrim, Northern Ireland -lets take a closer look and see if we can discover some of the reasons why...
The vertical columns and horizontal cracks indicate that this could be some sort of a lava flow -the main joints have developed perpendicular to the cooling surfaces. And it may appear that the lava flow is dipping towards the left but this isn't the case. It's simply an erosion feature brought about by the sea. Contraction of the lava flow as it collected has caused these hexagonal columns to form on cooling. Further cooling and shrinkage has formed these interesting convex and concave surfaces. Some of the columns are hexagonal. Others are seven sided ,five sided, or even four sided. We call this polygonal jointing.
We're not able to hammer here to get a fresh piece of rock because it's a protected site but there are plenty of fresh surfaces that we can look at. There's still not very much to see so we really need to look at a thin section. This shows a rock with a finely crystalline texture. The crystals are interlocking with random orientation indicating an igneous rock which cooled fairly quickly. Between crossed polars it contains small crystals of twinned plagioclase feldspar with first order interference colours, together with mafic minerals such as olivine and pyroxene though these are less obvious because they've been altered.
Looking at the thin section confirms that this is in fact a basalt, but there are other clues that we can look for.
Tratto da: Rocks in the field - for iPod/iPhone - iTunes U - The Open Univesity
giovedì 4 gennaio 2018
Fossile Guida - Paleontologia
 |
| Le Fusulinidae sono organismi unicellulari che, come tutti i foraminiferi, erano provviste di un guscio calcareo all'interno del quale viveva l'unica cellula di cui era formato l'organismo. Nella foto una fusulina, sezione longitudinale in luce trasmessa al microscopio ottico. |
Si tratta di resti di organismi che soddisfano precisi requisiti: avevano ampia distribuzione geografica,
una relativa ampia abbondanza di popolazioni e quindi sono facilmente rinvenibili nelle rocce sedimentate nel periodo della loro esistenza, hanno avuto un'evoluzione rapida: hanno quindi una durata temporale molto limitata e permettono di raggiungere un'elevata precisione nella datazione.
- Per il Paleozoico (542-251 milioni di anni fa): Trilobiti, Graptoliti, Ammoniti primitivi (Ammonoidei) e microfossili (Conodonti e Fusulinidi);
- Per il Mesozoico (251 - 65,5 milioni di anni fa): Ammoniti (Ceratitidi e Ammonitidi, come ad esempio Arietites) ed altri fossili microscopici (per es. Foraminiferi bentonici e planctonici per la datazione all'interno del Cretaceo, Tintinnidi);
- Per il Cenozoico (65,5 milioni di anni fa - oggi): microfossili, soprattutto foraminiferi planctonici e bentonici (nummuliti) e nannofossili calcarei.
 |
| I Trilobiti sono artropodi di ambiente marino esclusivi dell'era Paleozoica, costituiscono la classe Trilobita. |
martedì 2 gennaio 2018
Modulo di Poisson
Il modulo di Poisson (indicato anche come coefficiente di Poisson, coefficiente di contrazione trasversale o rapporto di Poisson) è una caratteristica propria di ciascun materiale (dipendente dalla temperatura) che misura, in presenza di una sollecitazione monodirezionale longitudinale, il grado in cui il campione di materiale si restringe o si dilata trasversalmente.
È definito come:

dove ν è il modulo di Poisson,  è la deformazione trasversale,
è la deformazione trasversale,  è la deformazione longitudinale.
è la deformazione longitudinale.
Il modulo di Poisson è un coefficiente adimensionale, con l'attenzione di osservare che tale relazione vale solo in uno stato di sollecitazione monodirezionale. In stati tensionali più complessi tale relazione non è più verificata ed il modulo di Poisson non coincide più con tale rapporto.
Il modulo di Poisson è correlato al modulo di elasticità ed al modulo di taglio dalla seguente relazione:
 è la deformazione trasversale,
è la deformazione trasversale,  è la deformazione longitudinale.
è la deformazione longitudinale.Il modulo di Poisson è un coefficiente adimensionale, con l'attenzione di osservare che tale relazione vale solo in uno stato di sollecitazione monodirezionale. In stati tensionali più complessi tale relazione non è più verificata ed il modulo di Poisson non coincide più con tale rapporto.
Il modulo di Poisson è correlato al modulo di elasticità ed al modulo di taglio dalla seguente relazione:

Valori limite per il modulo di Poisson ν
I valori del modulo di Poisson per materiali reperibili in natura sono compresi tra 0 e 0,5; il valore massimo corrisponde ad un materiale virtualmente incomprimibile (la gomma, ad esempio, ha valori prossimi a 0,5), mentre il valore minimo corrisponde ad un materiale con modulo di taglio tendente ad infinito.
Esiste tuttavia una famiglia di materiali, chiamati auxetici (per esempio il Gore-Tex), per i quali il modulo di Poisson può essere negativo: questo comporta, a seguito di una prova di trazione monoassiale, la presenza di deformazioni estensionali normali all'asse di sollecitazione di carattere positivo (ovvero un'estensione del materiale in direzione ortogonale a quella di sollecitazione), visto il legame che intercorre tra sforzi normali applicati e deformazioni normali conseguenti dettato dalla legge di Hooke (espressa in forma tensoriale) per materiali omogenei e isotropi.
Il campo di valori che compete al coefficiente di Poisson ν, dunque, risulta essere variabile tra −1 e 0,5:
I valori del modulo di Poisson per materiali reperibili in natura sono compresi tra 0 e 0,5; il valore massimo corrisponde ad un materiale virtualmente incomprimibile (la gomma, ad esempio, ha valori prossimi a 0,5), mentre il valore minimo corrisponde ad un materiale con modulo di taglio tendente ad infinito.
Esiste tuttavia una famiglia di materiali, chiamati auxetici (per esempio il Gore-Tex), per i quali il modulo di Poisson può essere negativo: questo comporta, a seguito di una prova di trazione monoassiale, la presenza di deformazioni estensionali normali all'asse di sollecitazione di carattere positivo (ovvero un'estensione del materiale in direzione ortogonale a quella di sollecitazione), visto il legame che intercorre tra sforzi normali applicati e deformazioni normali conseguenti dettato dalla legge di Hooke (espressa in forma tensoriale) per materiali omogenei e isotropi.
Il campo di valori che compete al coefficiente di Poisson ν, dunque, risulta essere variabile tra −1 e 0,5:
| materiale | modulo di Poisson |
|---|---|
| gomma | ~ 0,50 |
| oro | 0,42 |
| argilla satura | 0,40-0,50 |
| magnesio | 0,35 |
| titanio | 0,34 |
| rame | 0,33 |
| lega d'alluminio | 0,33 |
| argilla | 0,30-0,45 |
| acciaio inossidabile | 0,30-0,31 |
| acciaio | 0,27-0,30 |
| ghisa | 0,21-0,26 |
| sabbia | 0,20-0,45 |
| cemento | 0,20 |
| vetro | 0,18-0,30 |
| schiuma | 0,10-0,40 |
| sughero | ~ 0,00 |
| materiali auxetici | < 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post più visti negli ultimi 7 giorni.
-
Norme Tecniche delle costruzioni 2018 3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE Categorie di sottosuolo. Ai fini della de...
-
Successione degli orbitali in ordine crescente di energia: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f →5d → 6p → 7s → 5f...
-
In chimica, il raggio atomico è definito convenzionalmente la metà della distanza internucleare tra due atomi dello stesso elemento, legati...
-
Le Rocce sono aggregati naturali formati da uno o più minerali, costituiscono la litosfera, in base alla loro genesi vengono divise in t...
-
Il limite K-T è il termine con cui si indica il passaggio, datato a 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa tra Cretacico e Cenozoico nelle succes...
Post più visti in assoluto
-
Il disseccamento del Mediterraneo alla fine del Miocene di Maria Bianca Cita Università di Milano Il piano Messiniano rappresenta u...
-
Il piano Messiniano rappresenta un periodo di tempo molto breve nella scala geologica (meno di due milioni di anni) nella parte terminal...
-
Il limite K-T è il termine con cui si indica il passaggio, datato a 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa tra Cretacico e Cenozoico nelle succes...
-
Un modello matematico descrive le dense nubi di gas e ceneri che scorrono lungo i fianchi del vulcano durante un'eruzione esplosiva....
-
Successione degli orbitali in ordine crescente di energia: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f →5d → 6p → 7s → 5f...
































